di Robespierre Capponi
In quell’inizio di primavera un po’ stramba, il nostro obiettivo era quello di arrivare a Firenze, cioè di fare più o meno centotrenta chilometri in quattro giorni, avventurandoci lungo la via politeista che unisce Bologna a Firenze, ovvero il sentiero degli dei. Con lo zaino in spalla, e la necessità di liberarci dai patemi di una quotidianità pandemica fatta di zone a colori e insulsi divieti, ci incamminammo di buon’ora verso la Basilica di San Luca, dove per arrivarci si percorre il portico più lungo al mondo, tutto, o quasi, in salita.
Dopo aver lasciato il parco della Chiusa, ci capitò la fortuna di non incontrare anima viva fino a Monzuno, dove si concludeva la nostra prima tappa. Sarà stato per via di quella buona sorte, di quel silenzio eloquente accompagnatore del nostro cammino, che ci prese come una vaga sensazione d’incontrarli per davvero gli dèi, e forse sarebbe potuto anche accadere se solo non avessimo avuto con noi dei sensi così grossolani. Infatti, quando ci capitava di passare in mezzo a un’abetaia, mentre che eravamo concentrati nel buttare avanti uno dopo l’altro i nostri passi, avevamo come la sensazione che sopra la nostra testa stesse succedendo qualcosa di molto importante, avvertivamo un certo misterioso convegno tra il fruscio delle foglie, il cinguettio degli uccelli e il soffio del vento. Ma cos’è che aveva da dirsi di così importante la combriccola dell’abetaia? No, i nostri organi di senso non sono uno strumento sufficientemente sensibile per rispondere a questa domanda. Allora è forse per questa impossibilità di capire i linguaggi della natura che abbiamo deciso di prosciugare ruscelli e fiumi, e di sventrare montagne e abbattere alberi?
Il fatto è che questa perplessità avrebbe meritato senz’altro una sosta di qualche minuto per rifletterci un po’ su, se solo l’ingegner «A» ci avesse lasciato il tempo di farlo. L’ingegnere, la guida del nostro gruppo, possedeva una certa frenesia tipica di certi sportivi, quella di portare a termine la missione in un preciso arco di tempo. Il tempo dell’orologio.
Avanzavamo in fila indiana, l’ingegner «A» guidava il gruppo con il suo passo deciso e costante. Noialtri, cioè io e «B», lo seguivamo con molta determinazione. «B» si era portato appresso i batacchi da passeggio, quelli che vendono nei negozi di articoli sportivi specializzati nel trekking, e per fortuna ne aveva dato un paio anche a me che chiudevo la fila e mi chiamo «C».
«A» ci trascinava lungo i sentieri, c’incoraggiava, a volte ci ammoniva a non perder tempo con certe filosofiche stupidaggini spronandoci al pragma, alla concretezza, al compartimento stagno: eravamo lì per un obiettivo, e per nessuna ragione al mondo ci saremmo fatti distrarre dal subdolo e galattico interpensiero. Bisognava arrivare alla meta senza star lì troppo a fantasticare su ciò che non può essere né attuato né decodificato. Come per esempio la molecola vagabonda che vagava nell’aria e, per caso e controvoglia, visitava sovente il mio naso per comunicarmi chissaché.
La salitaccia di monte Adone metteva a dura prova i nostri muscoli, l’ingegnere però sembrava non soffrire le pendenze, gli strappi della salita, il fiato grosso. Io e «B», invece, arrancavamo, e nel frattempo imparavamo sul campo che cosa concretamente significasse rompere il fiato. Arrivati finalmente in cima bevemmo un meritato sorso d’acqua mentre l’aria pizzicava senza pietà le nostre schiene piene di sudore e nel contempo le cellule, prigioniere dell’acido lattico, ci comunicavano impazienti la loro pazza voglia di ossigeno.
Incapaci di recepire sia il linguaggio delle cellule che quello della natura, buttammo arditi gli occhi attorno a noi, la vista della vallata mozzava il fiato. Respirammo a pieni polmoni. Poi ci voltammo in direzione delle nostre spalle, cioè dietro di noi, e proprio in quel momento ci accorgemmo, pressoché allibiti, di aver percorso «TUT-TA QUEL-LA STRA-DA!».
Questo fatto produsse nei nostri corpi un sentimento mai provato prima. La vista di tutto quel segmento di strada percorso, installava nei nostri cuori una chiara sensazione di soddisfazione, di appagamento, di piacevolezza, ma allo stesso tempo di stranezza, poiché non era affatto consueto guardarsi indietro e provare piacere. Quella gagliarda sensazione era moltissimo differente da quel tipico umor freddo e nero di quando si guarda al proprio passato, a certi istanti andati via per sempre, quella sensazione non aveva nulla a che fare con quei tipici rimpianti per aver scelto quel sentiero piuttosto che quell’altro; in mezzo a quelle catene di montagne, la strada percorsa era fonte di inaspettato piacere, di ambizioni, di cari passati, presenti e futuri.
Speranzosi, ci rimettemmo in cammino non prima di aver bestemmiato contro la società dei preti, e la loro inaccettabile smania nel voler a tutti i costi piazzare il proprio simbolo dappertutto, persino sulla cima del monte Adone, dando per scontato che il crocifisso appartenga a tutti. È di tutti, semmai, il diritto al panorama, alla bellezza, alla felicità; e, perché no, ad averci un passato senza rimpianti.
L’albergatore di Monzuno ci accolse con una doccia, un letto e delle squisite tagliatelle al ragù. Quando indolenziti, ma pieni d’immagini e pensieri inconsueti, ci ritirammo nelle nostre stanze, incominciai a leggere «Il sentiero degli dei» di Wu Ming 2, fino a quando non mi prese il sonno, un sonno bello: senza confini, pieno di sogni.
To be continued (forse)…
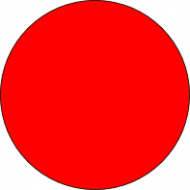

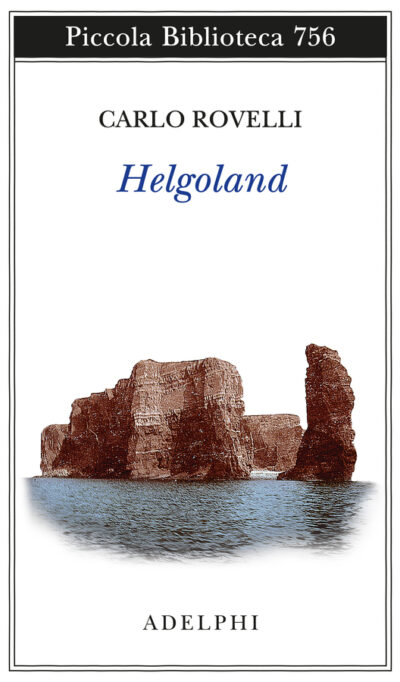

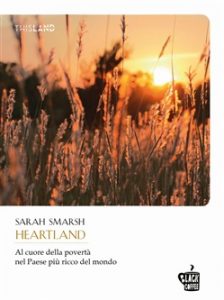 di Alessandra Banfi
di Alessandra Banfi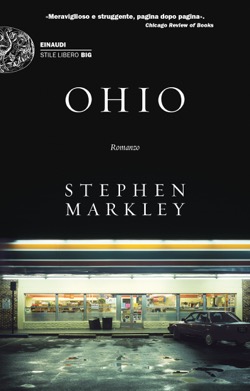
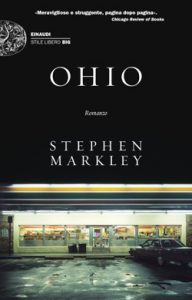 ‹‹Per ora sappiate che è successo qualcosa.››
‹‹Per ora sappiate che è successo qualcosa.››




 di Sara Maria Morganti
di Sara Maria Morganti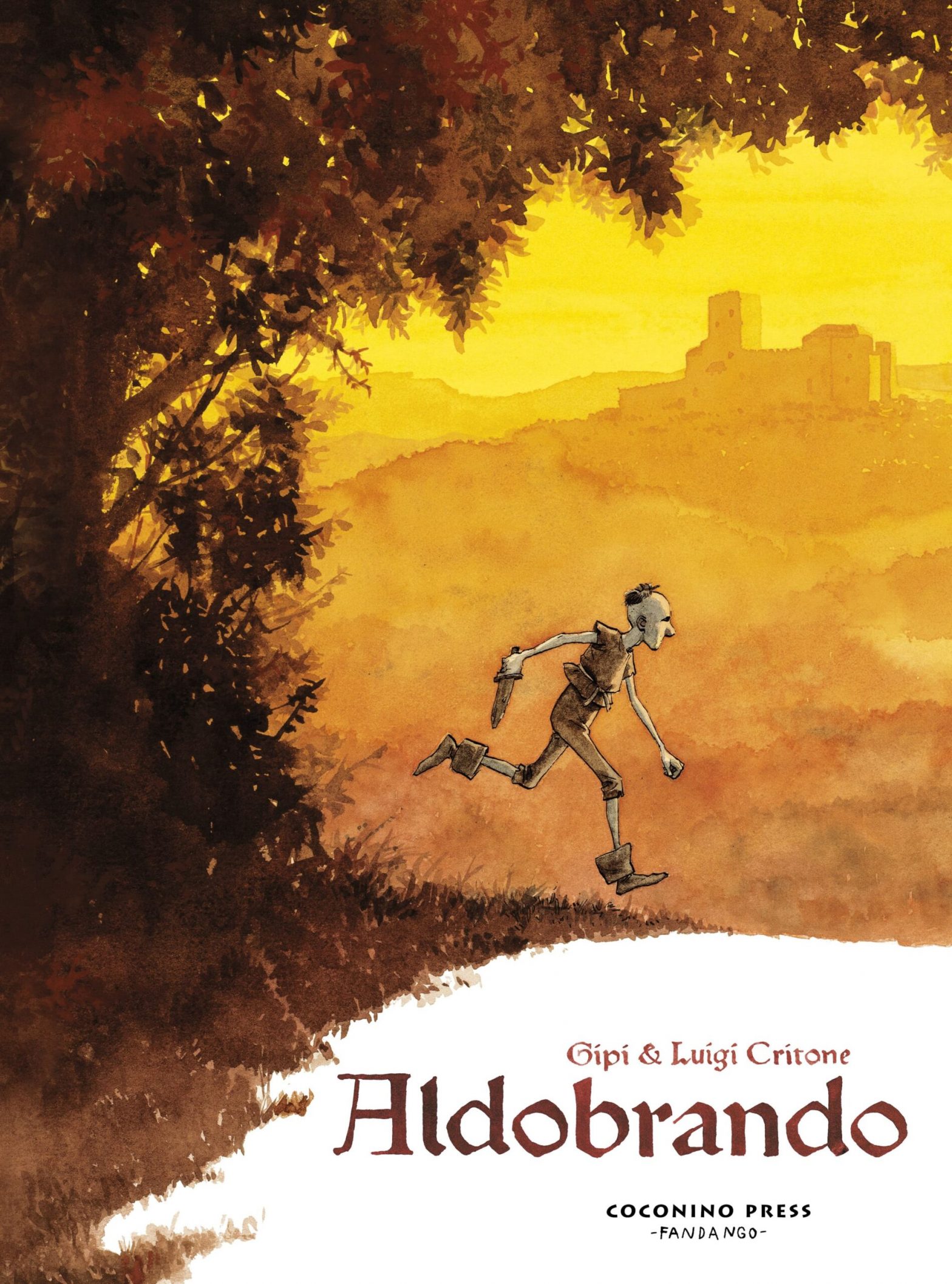
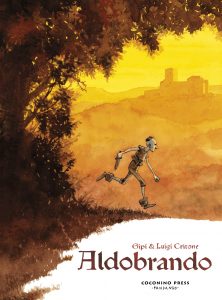
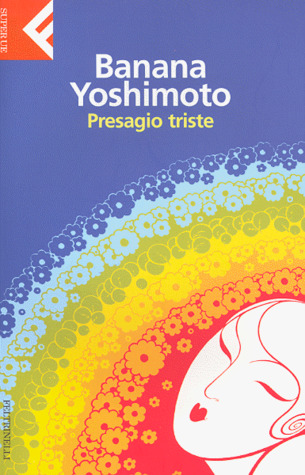
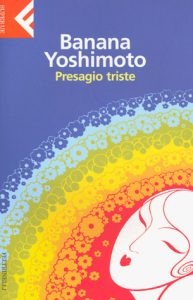 di Alessandra Banfi
di Alessandra Banfi
