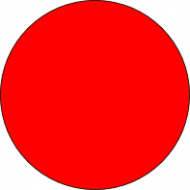di Giovanni Di Prizito
‹‹Le parole hanno la mobilità di una marionetta, un’ossatura invisibile di legno e di fil di ferro, come quella che sostiene i pupi siciliani. È tutto un affare di chiodi e cordicelle.››
Succede che, certe volte, le parole sono come le medicine. E come certe medicine, più ne prendi più ti senti meglio. Succede che, con l’occhio clinico, è necessario adocchiare quelle giuste, di parole. Quelle indicate, quelle adatte al malanno insomma. Questo succede.
Questo mi è successo in una fase precaria dell’animo non più tardi dell’isolamento passato. Una di quelle fasi in cui non sai bene stare al mondo. Una di quella fasi che è meglio se non ti succede, specialmente nell’appartamento dentro all’isolamento – sai che paturnie! Comunque alla fine le ho adocchiate, quelle giuste. E con le parole mi ci sono curato.
Allo stesso modo delle medicine. Più ne prendevo, più non mi volevo fermare, per nessuna ragione di questo mondo, nemmeno per quella cosa che mi aveva fatto isolare da tutto e sopra a cui tutti, ma proprio tutti, parlavano e scrivevano – piripì parapà piripì parapà. No. Per nessuna ragione di questo mondo avrei voluto smettere di assumerle. Altro che guanti, mascherine e pazienti zero.
Dieci. Dieci dichiarazioni d’amore che Fabio Stassi – Primario della Parola e autore di Con in bocca il sapore del mondo, Edizioni Minimum Fax 2018 – somministra a piccole ma grandi dosi, una o tutte le volte del giorno, prima, durante e dopo i pasti ai suoi pazienti immaginari ma anche reali. Fabio Stassi fa ri-vivere dieci Poeti del Novecento immaginandoli, facendoli immaginare, in prima persona a raccontare la loro storia, le loro ossessioni, i loro desideri, le loro allegrie e i loro dolori. Fabio Stassi, dentro all’isolamento, mi dava la possibilità di guarire. E finalmente di parlarci, con i Poeti.
‹‹[…] Gli uomini che prendono sul serio gli altri mi hanno sempre fatto compassione, quelli che prendono sul serio se stessi mi facevano sganasciare›› mi diceva Aldo Palazzeschi. E allora cominciavo a capire che forse il male dell’anima dipendeva proprio da questo, dal non riuscirne a ridere. Era questo che non mi era mai riuscito di fare, ridere di me medesimo. ‹‹[…] Le parole hanno la mobilità di una marionetta, un’ossatura invisibile di legno e di fil di ferro, come quella che sostiene i pupi siciliani. È tutto un affare di chiodi e cordicelle›› aggiungeva Salvatore Quasimodo. Ebbene, mi sentivo sostenuto anche io, mi sentivo come un pupo siciliano.
Come un pupo siciliano mettevo in scena la mia storia, la mia tragedia. I Poeti mi manovravano mentre io mi abbandonavo alle loro premure e alle loro cordicelle. E le parole agivano, dentro di me, mentre Guido Gozzano mi raccontava dei suoi turbamenti, che erano anche i miei. ‹‹Il mio problema è sempre stata la gravità, questo sentirmi sempre sbagliato, fuori stagione, fuori norma, fuori misura. Troppo pesante per le frivolezze del mondo e dei tempi, e troppo leggero per la realtà.››
Correndo, senza pararmi nemmeno per il servizio igienico, arrivai fino alle ultime. Quelle della Poetessa, quelle sui matti. ‹‹[…] Al manicomio›› diceva lei, ‹‹si è tutti impreparati. […] Fu solo quando mi ci trovai che credo di essere impazzita per davvero di terrore […] Per i matti non c’è comprensione […] Perché la follia, per gli occhi del mondo, è una mala metafora, non una malattia. È una metafora della colpa. Una responsabilità. […]››
Tutto, intorno a me, possedeva qualcosa che non la so dire, qualcosa che non la so spiegare con il rumore dei tasti. Qualcosa di assai. Mi sentivo addosso come una stranizza d’amuri. Quelle parole continuavano a muoversi, una per una mi sostenevano e mi facevano guarire, una per una si prendevano cura di me. Mentre io, anche se le pagine erano finite, continuai a parlarci. Con i Poeti.