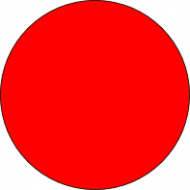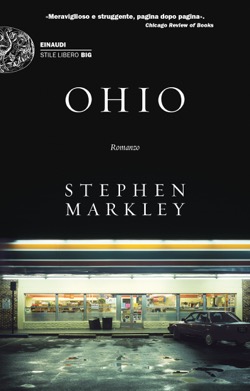di Alessandra Banfi
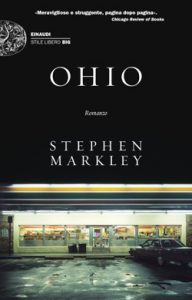 ‹‹Per ora sappiate che è successo qualcosa.››
‹‹Per ora sappiate che è successo qualcosa.››
Dimentico subito questo consiglio. Lo dimentico in modo ingenuo, perdendo la rotta tra i gesti del ragazzo che incontro nel primo capitolo, Bill, fulminato dall’acido e reduce da quattordici ore di viaggio in auto.
Da bordo pagina lo osservo a bordo strada. È rimasto a piedi. Il suo pick-up sgangherato ha il serbatoio vuoto e la stazione di servizio più vicina è a tre chilometri da lì. Bill è appena tornato nel posto in cui è nato. Un marasma di ricordi si ingarbuglia alle allucinazioni che portano a spasso il suo cervello verso squarci di universo sconosciuti. Bill impreca, ride e si dispera. Lo seguo incuriosita e mi distraggo. Per questo mi dimentico che è successo qualcosa. Per questo, anche se Bill ha un appuntamento con non so chi e un pacco di non so cosa da consegnare, io comincio a credere che forse il nocciolo del discorso sia questo. Il ricordo. Uno spazio sigillato nel quale nascondere quello che ti pare. Un posto in cui sentirsi al sicuro. O una macchia sbiadita, mai del tutto scomparsa, capace di rovinare per sempre il tuo abito preferito.
Non è difficile immedesimarsi e incrociare vecchi amici segnati dalle intemperie della vita, ma avverto lo stesso un po’ di ruvido sulla pelle. Non sono mai troppo felice quando incontro qualcuno con cui ho tagliato i ponti. La distanza creata con coscienza è un affare così delicato che basta un niente per rovinare l’abitudine ad un’assenza.
Poi, a un tratto, seduta ad ascoltare le chiacchiere stiracchiate tra un uomo a cui è rimasto un solo occhio buono e una donna che non ha mai smesso di pensare a lui, realizzo che oltre alla questione dei ricordi c’è dell’altro. Ritorno a quel consiglio. È successo qualcosa. Mi guardo attorno per chiarire la situazione. Come posso esserci cascata? Scuoto i ricordi e allontano la nostalgia che mi ha fatto prendere la strada sbagliata. Ora sembra tutto così viscido e pericoloso. Annaspo tra i dettagli, mi infilo tra le ombre di un passato che non mi appartiene e che tuttavia ha il potere di risucchiarmi per svelare la sua verità. Una verità che si contorce insieme al mio stomaco. La provincia americana diventa così vicina e racconta un male dai contorni sfumati nel quale i ruoli di vittima e carnefice si mescolano fino a confondersi. Preferirei non sapere e non vedere, ma non posso – non voglio – chiudere gli occhi e spegnere la testa, così ascolto, osservo. Quello che è successo mi fa un male cane. Leggo in apnea. Capisco solo adesso. Arrivano il buio, il silenzio. Ho i muscoli indolenziti. Provo un dispiacere che si avvicina all’angoscia, ma c’è spazio per l’ultimo incontro. Per l’ultimo flusso di parole sotto un temporale che inonda la città scrosciando fiotti di pioggia. Cerco di riprendermi. Vorrei tanto avvicinarmi per dire a S: “Ehi, ha pensato a te. In quel momento là, ha proprio pensato a te”. Ma io sono qui e lei non può sentirmi.
Arriva la fine. Chiudo il libro piano piano per non fare del male a S.
S. che ha sfiorato la verità e un giorno, ne sono sicura, riuscirà a ricomporre i frammenti di ciò che è stato.