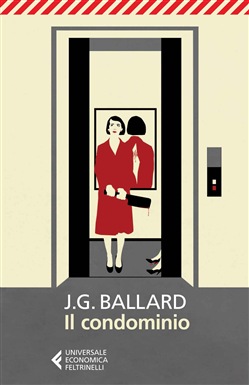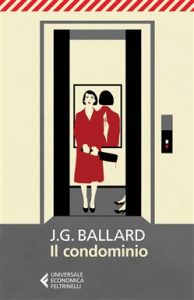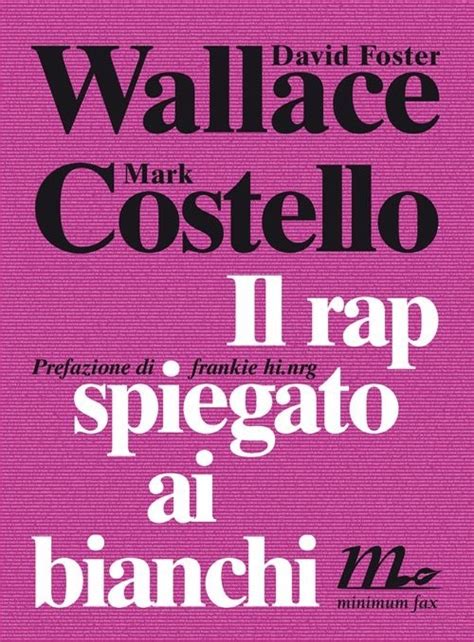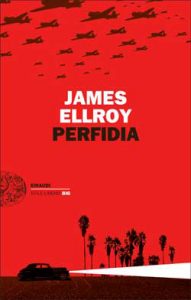
di Robespierre Capponi
«Ha scoperto la vera Quinta Colonna. E non è quello che pensa la gente».
Chi è l’uomo bianco con il pullover viola? È quello che ci si chiede nelle 882 pagine di Perfidia di James Ellroy, il primo libro del nuovo quartet dedicato a Los Angeles, pubblicato da Einaudi editore.
Il dottore della scientifica Hideo Ashida, il sergente Dudley Liam Smith, il capitano “whiskey” Bill Parker, ed io ci stiamo rompendo la testa a forza di chiedercelo: chi è l’uomo bianco con il pullover viola?
Il suono di una moltitudine di relazioni cellulose aleggia ancora nell’etere, lo si può avvertire anche tra queste pagine digitali, è sufficiente appiccicare l’orecchio allo schermo come sto facendo io in questo momento: sì, sento l’eco del crepitio di sinapsi, sono ancora lì a bisbigliare del come e del quando e del perché.
Il contesto dove ci troviamo è presto detto: Los Angeles. È il 1941, tempo di guerra: al di là dell’Oceano Atlantico, l’Europa è quasi tutta in mano ai nazifascisti, a resistere sono rimasti solo gli inglesi e i comunisti di ogni latitudine. I giapponesi, invece, hanno avuto la stravagante idea di attaccarci a Pearl Harbor, affondando la flotta del Pacifico. Praticamente un suicidio: gli faremo il culo!
A proposito di suicidio, proprio il giorno prima dell’attacco, cioè il 6 dicembre 1941, una intera famiglia di giapponesi è stata trovata morta nel proprio appartamento, pare per via di un suicidio rituale, un seppuku e qualcosa, una di quelle pratiche strane dei giappi. I corpi senza vita sono stati ritrovati sventrati uno accanto all’altro sul pavimento del soggiono. Di fianco ai corpi senza più budella, quattro spade sporche di sangue: è davvero un suicidio collettivo o un crimine? Grazie ad alcune analisi della scientifica che non sto qui a spiegare, propendiamo per la seconda ipotesi. Il capo della polizia Jack Horral vuole dare molto spazio a questo caso poiché i giapponesi, dopo l’attacco infame a Pearl Harbor, sono nell’occhio del ciclone. In più Jack vuole che si trovi un assassino giappo, vuole che lo si dipinga come un mostro, per poi darlo in pasto all’opinione pubblica collaborazionista, e lo vuole entro capodanno.
Non passerà molto tempo che interneremo i cittadini americani di origine giapponese per tutto il periodo del conflitto mondiale; ed entreremo in guerra a fianco degli alleati contro il famigerato Asse. A dir la verità, avremmo preferito allearci a Hitler e al suo compare Mussolini piuttosto che ai comunisti, poiché il nostro grande nemico sono i rossi, non certo i nazifascisti, anche se hanno un po’ esagerato con quei giudei…
Zompo un attimo fuori dal libro, cioè dal 1941, per far ritorno all’attualità, cioè il presente di fine pandemia e di lotte globali contro il razzismo e soprattutto contro la violenza della polizia. Pochi giorni fa mi è venuta voglia di scrivere “ACAB” sul muro e l’ho fatto (volevo scrivere il più criptico “1312”, ma poi ho optato per la chiarezza). Ora che ci penso mi fa un po’ specie aver avuto come compagni di avventura dei poliziotti (peraltro senza scrupoli), ma la letteratura spesso conduce dove non te lo saresti mai aspettato, ad apprezzare scrittori conservatori o a identificarti persino con un sergente razzista della polizia di Los Angeles, chiamato Dudley Liam Smith per il quale io sono solo un wop, un guappo. Il Dudster non contiene neppure un atomo di sensibilità, eppure mi ha fatto venire voglia di diventare un suo protetto, di sapere che effetto fa ammazzare un giappo a bruciapelo, di riempirmi di benzedrine e altre cose che non si possono dire, tipo andare a letto con Bette Davis. Mi è venuta voglia anche di provare l’oppio nella pagoda di Zio Ace, per evadere dalle inutili tribolazioni quotidiane, dal malvagio passato presente futuro, e da me stesso. Mi è venuta anche voglia di fare soldi in modo illecito, solo che non so come si fa. Fottesega di quello che vanno dicendo i Proverbi 3, 31: «Non invidiare l’uomo violento e non imitare affatto la sua condotta».
No, non so chi sia l’uomo bianco con il pullover viola, e neppure m’interessa, cioè sti cazzi, io sto con Bette Davis. Ho appena dato un bigliettone da 100 dollari al cameriere in livrea. C’è anche John Wayne nella sala, ha baciato il braccio di Bette e io ho preso in mano la pistola per ficcargli una pallottola nelle cervella, non so neanche perché non l’ho fatto. Poi Bette mi ha spezzato il cuore buttandomi addosso queste parole qui: «Come osi pensare che io e te siamo più di una triviale nota a piè di pagina di questo orribile periodo»… Ho fatto un casino.
Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire su questo libro molto denso, per esempio cosa avrebbe da dire su tutta questa storia Kay Lake, la ragazza cazzuta della prateria di Sioux Falls, nel South Dakota, scappata a Los Angeles da un «destino insufficiente», ma questo lo lascio scoprire al magnifico lettore.
Vorrei concludere dicendo che secondo me leggere l’Ellroy di Perfidia è molto più appassionante di qualsiasi serie del cazzo su Netflix (vabbè, a parte Better call Saul).
Vorrei anche ringraziare James Ellroy, grande scrittore, per avermi fatto compagnia in questa strana pandemia, ma soprattutto vorrei ringraziare chi mi ha prestato questo libro, cioè una mia amica di Parigi, che però adesso si è trasferita a Lione. Ora che ci penso, ho rischiato una multa salata per prendere possesso di Perfidia, ho varcato le cosiddette colonne d’Ercole della pandemia, cioè un chilometro senza autocertificazione, per averlo; ho infranto la legge e ne è valsa davvero la pena.

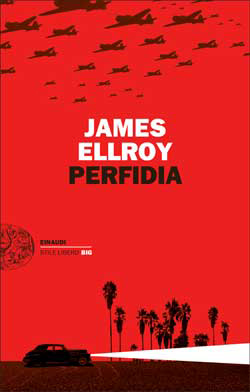



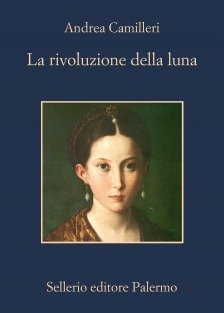
 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi
 di Giovanni Di Prizito
di Giovanni Di Prizito
 di Sara Maria Morganti
di Sara Maria Morganti