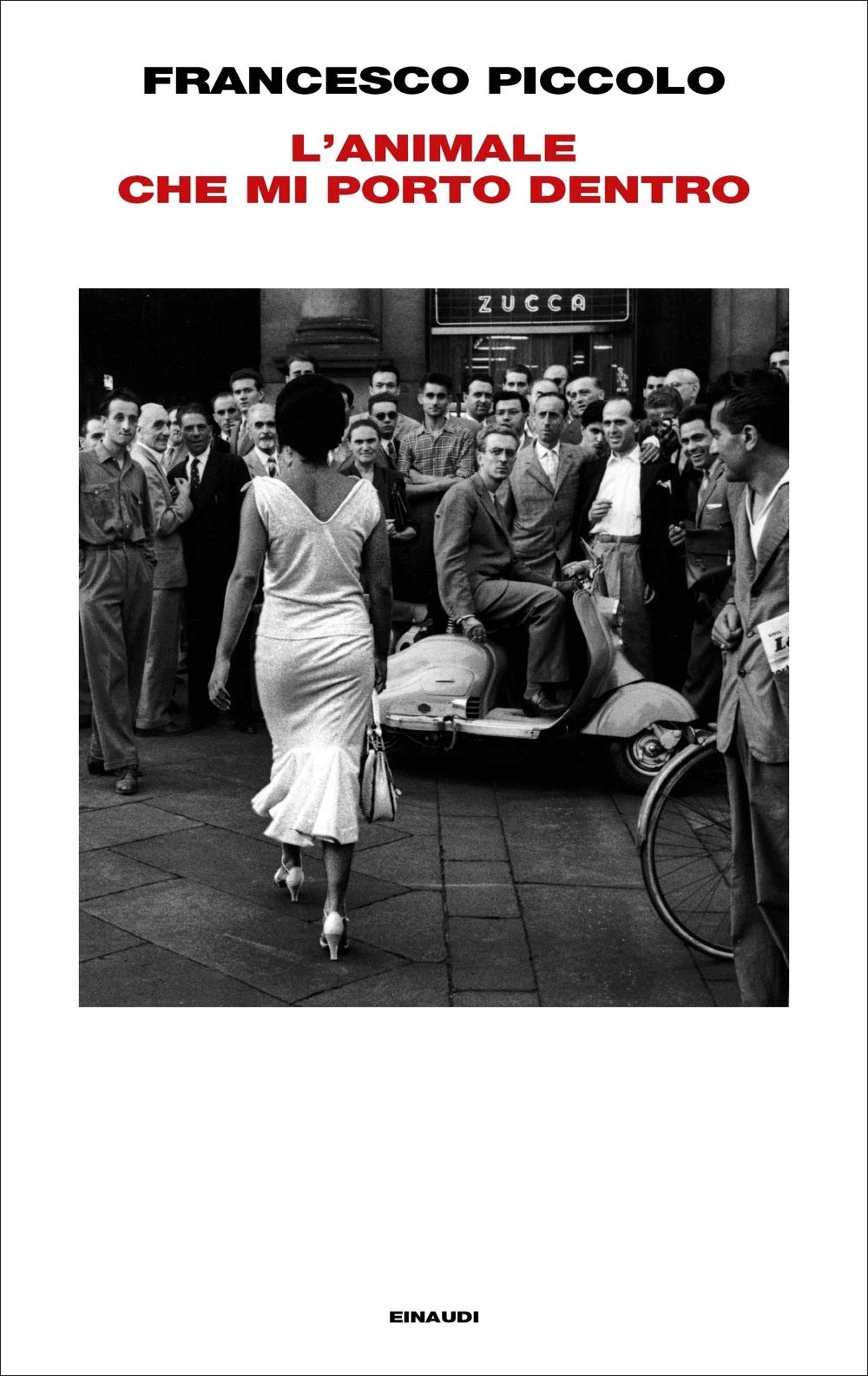di Giovanni Di Prizito
‹‹Ogni storia di uomo, matto o normale, è una mescolatura delle stesse cose, na cascanna di lacrime, qualche sorrisetto, na cinquina di gioie di straforo, e un dolore grosso come quando al cinema si spengono le luci.››
Certi libri sono come gli odori, riescono a trasportarti nel momento e nel luogo esatto in cui li hai letti per la prima volta. In un certo senso ti fanno viaggiare nel tempo. Quello che ho ripreso oggi, per esempio, l’ho letto in uno di quei momenti quando la vita la senti divampare dentro, un’esplosione emotiva che ti fa sentire un poco matto e un poco bambino. Quando lo stomaco si chiude, il cuore fa tututum tututum tututum tututum, le immagini scorrono e tu non puoi fare altro che sfiorarle. Questo puoi fare, niente. Fermo. Immobile. Non toccarle. Non dire una parola.
Se poi il libro in questione è su una cocciamatte, cioè su uno che parla da solo e che si mette le pietre in tasca per la paura di volare via, che usa poco la ragione e assai il cuore, che sente i rumori in testa e che vede quello che non c’è, un altro insomma un poco matto e un poco bambino, forse, in uno di quei momenti là, tra paturnie e piagnistei è meglio rimandarla la lettura. Ma se già dalla prima pagina dentro a quel libro ci entri pure tu rimandarla diventa impossibile, allora chiudi gli occhi e ti ci butti dentro alle fiamme.
Bonfiglio Liborio, per duecento-cinquanta pagine, mi ha preso la mano e mi ha fatto camminare insieme a lui, da quando è nato nel 1926 a quando è morto nel 2010. Bonfiglio Liborio mi ha raccontato, in prima persona e con la lingua tutta sgarbugliata, quello che ha vissuto, da quando era piccolo a quando era grande: scuola, apprendistato da barbiere, militare, case chiuse, guerra, Resistenza, lavoro in fabbrica, sindacato, manicomio e solitudine. Gli amori perduti, quelli ritrovati, gli amici operai, i segni neri, i rumori in testa, il maestro Cianfarra Romeo, il libro Cuore e il medico dei matti. Bonfiglio Liborio, in una giostra popolare di fallimenti, rivincite, solitudine e malinconia lunga ottanta-quattro anni, mi ha raccontato il coraggio e la follia. E più parlava, sempre tutto sgarbugliato, più il rumore aumentava – tututum tututum tututum tututum.
Io allora, a pensare e ripensare alle paturnie mie, mi sentivo come a lui, ‹‹tutta na matassa sgarbugliata fuori di cervello›› che non riusciva a fermare il rumore, ‹‹[…] perché uno più ricordi ha e più ci soffre di cuore, perché i ricordi sono solo ricordi e le cose che ti ricordi non tornano indietro vive […]››. La ragazza di fronte con la guida di Palermo, quella rannicchiata dall’altro lato che si mangiava le unghie – Dio che fastidio, quella che leggeva il libro sulla felicità, la signora al telefono che si lamentava delle ernie cervicali mentre io pensavo a quelle lombari, quella che sempre al telefono urlava prondo! prondo! e l’altra che rideva tutta scomposta, la bambina con il quaderno di Peppa Pig, il signore con le parole crociate e il cappello da pescatore, il controllore che controllava, la voce che contingentava, la sicurezza, la distanza, la mascherina, l’alcol, il disinfettante e i guanti. Tutto mi sembrava irreale. Tutto mi sembrava immaginario. Sopra a quel treno di primavera, in mezzo agli sconquassamenti dell’anima, tutto mi sembrava sbagliato. L’unico che mi capiva era Liborio. Gli altri invece mi guardavano come si guardano i matti, impauriti.
Era chiaro. Era prevedibile. Stavamo diventando una cosa sola. Io e Liborio camminavamo mano nella mano fregandocene delle ansie fameliche e di tutto il resto di questo mondo, tanto quelli come noi non li capisce nessuno, vanno solo messi al manicomio ‹‹[…] che è come una libreria dove al posto dei libri ci stanno i matti, tutti belli affilati nelle camerate proprio come i libri sullo scaffale […]››. Liborio mi raccontava di quando ce lo avevano portato per davvero allo ‹‹spedale pissichiatrico››, mentre io pensavo che per fortuna non esistevano più e che quindi me l’ero scampata. Pagina dopo pagina Liborio diventava il mio curatore, guaritore e confessore, altro che matto, le sue parole facevano la luce e domavano l’incendio. E io ormai l’avevo capito, ‹‹[…] tutto dipendeva dalla mia forza di dentro […]››, solo che ‹‹non sapevo se quella forza ce l’avevo e dove la dovevo cercare […]››.
Ecco. Oggi che rificco il naso tra quelle pagine raggrinzite e ancora bagnate, oggi che riprendo in mano “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino e che rifaccio un pezzo di strada insieme a lui l’odore è lo stesso di quei momenti là. E allora oggi diventa ieri e io torno al treno, al viaggio di primavera, al confinamento, alle paturnie e ai piagnistei, alle immagini sfiorate, agli sconquassamenti dell’anima, ai ricordi mezzi vivi e mezzi morti, alla guida sicula e al cuore tutto sgarrupato che faceva rumore e penso, e un poco mi viene da sorridere a pensarlo, che alla fine Liborio non si era sbagliato, ‹‹perché ogni storia finisce, e se finisce, finisce, e non ci sta più parola da dire.››

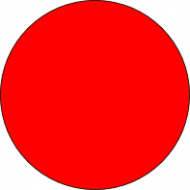


 di Alessandra Banfi
di Alessandra Banfi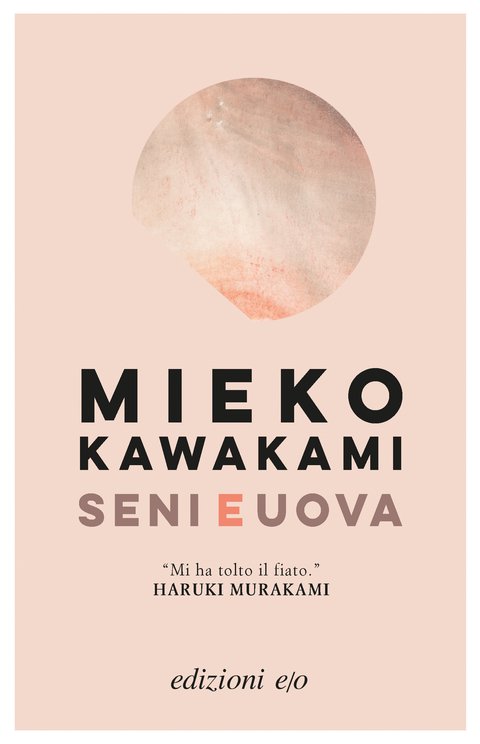
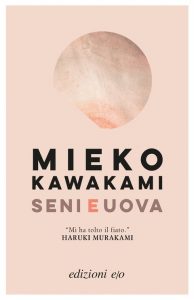
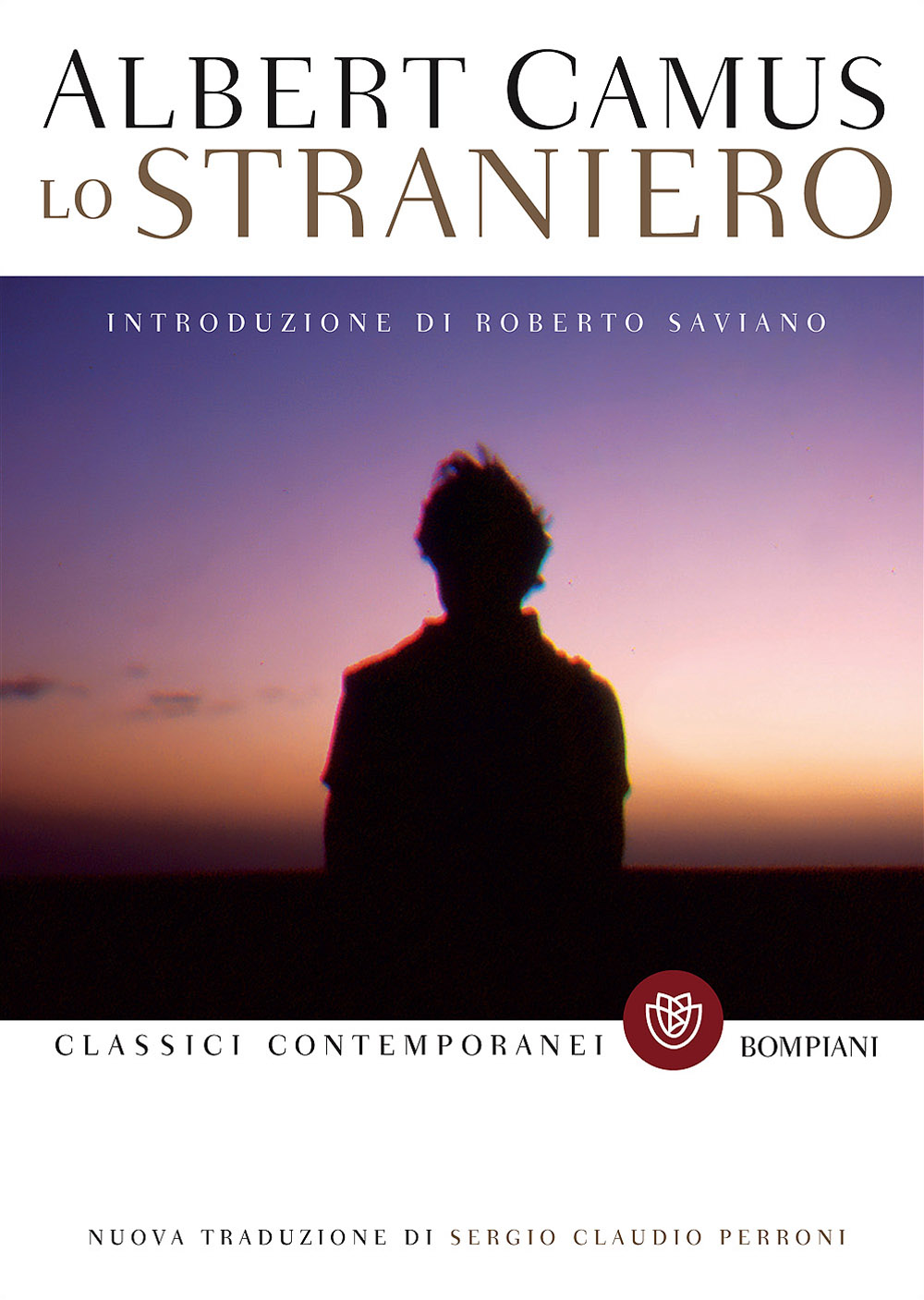
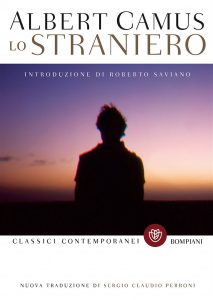 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi

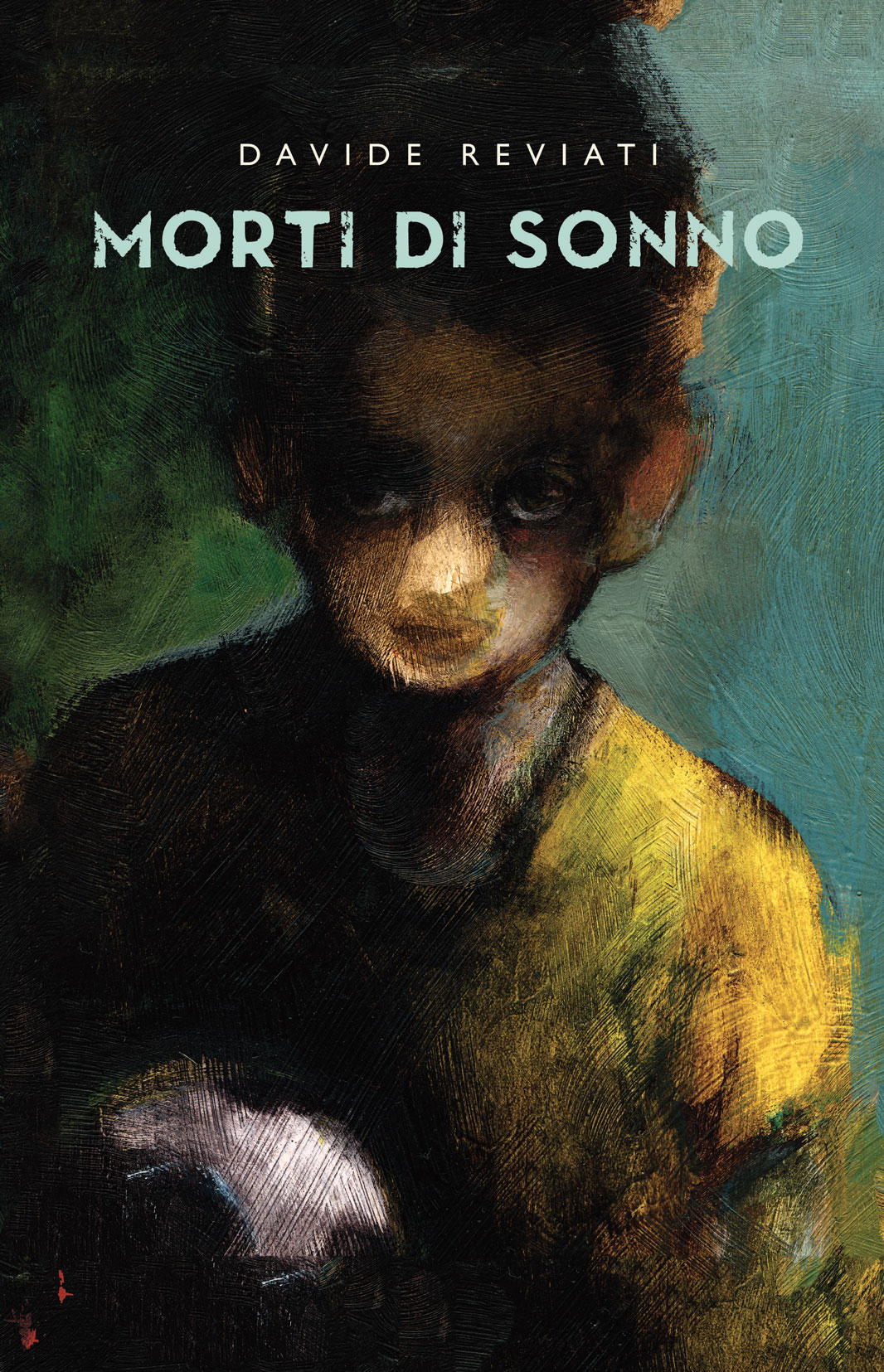
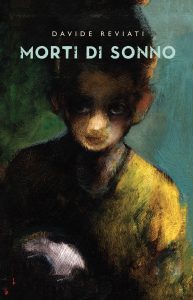

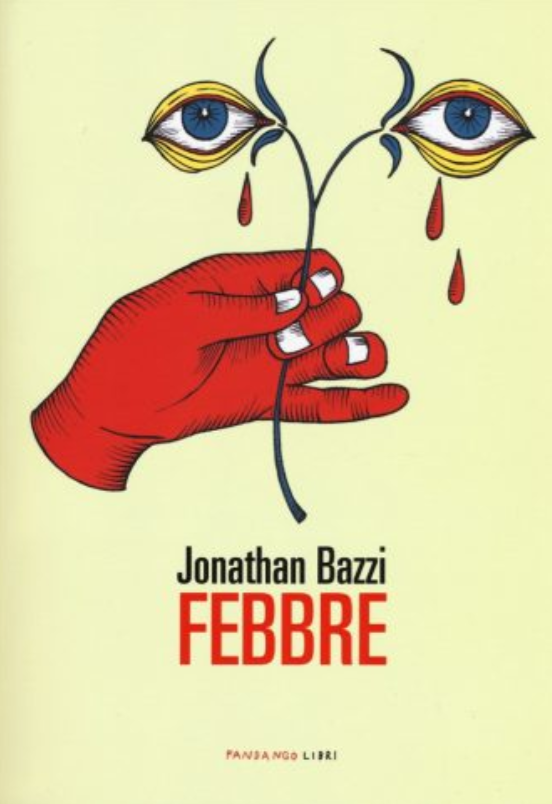
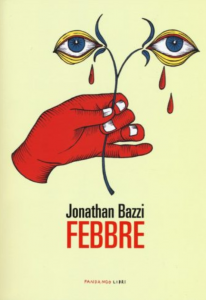

 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi