
di Alessandra Banfi
«Era da qualche giorno che ci pensavo. Cioè, pensavo a cosa avrei provato nell’affrontare un viaggio, come un tempo, quando stavo bene e odiavo restarmene a casa per una giornata intera. Si fatica, sai, a ricordare una vita che non ti appartiene più. È come tentare di far tornare alla memoria pezzi di storia di un’altra persona.»
So cosa vuol dire.
Stare sulla soglia di casa e avvertire le vertigini solo per aver considerato la distanza tra il tuo corpo e l’auto che hai parcheggiato lì fuori. E devi raggiungerla, quell’auto. Devi farlo adesso. Devi pure darti una mossa perché sei in ritardo.
(Saranno trenta metri. Più o meno. Ma tu sai che non ce la farai. E che da qui a lì succederà qualcosa di spaventoso, tragico, traumatizzante).
Entrare in un negozio e uscire subito dopo perché il locale ti sembra troppo piccolo, troppo buio, troppo stretto e ti senti soffocare… o magari perché è troppo grande, troppo affollato, troppo pieno di quella luce artificiale che ti riempie gli occhi e ti sdoppia la vista.
Scegliere la strada più lunga, ma meno trafficata (altrimenti sai che brutto se ti piglia il panico proprio davanti al semaforo rosso e non puoi premere l’acceleratore per scappare e distrarti?).
Fare chilometri per trovare un supermercato piccolo-piccolo con corsie spaziose, ben illuminate (ma non troppo), comodo parcheggio, nessuna attesa alla cassa.
Più dentro che fuori. Lo sono da un pezzo, forse da sempre.
Le gambe inchiodate, la schiena irrigidita, la testa che fa scintille e a un tratto non c’è più. Esplode. O implode, che ne so, fa lo stesso. Diventa in ogni caso inutilizzabile. Pausa. Tempo scaduto. Fine corsa. Si accomodi, prego, vuole un bicchiere d’acqua?
Momenti da sceneggiatura thriller. Ho provato a ignorare queste sequenze dell’orrore. Ho provato a piangermi addosso. Poi ho cercato di raccontare. Di riderci sopra.
Ora dico vabbè, posso farcela anche così.
Con Più dentro che fuori di Alessandra Scagliola, edito da Morellini, ho riso tantissimo. Ho riso perché certe fobie-ossessioni-nevrosi possono essere drammaticamente comiche. Lo possono essere anche quando assomigliano a quelle che conosci tu (o forse lo sono proprio per questo).
Se ci penso bene, a voler seguire la logica, avrei dovuto provare una gran paura, aprendo un libro così. Invece ho letto una pagina e un’altra e un’altra ancora e ho riso di continuo, davvero. E quando rido tutto sembra più facile, attraversabile, innocuo.
(Un potere incredibile, quello che ti permette di suscitare una risata negli altri. E lei, l’autrice, riesce a farlo con scioltezza).
La mia è stata una risata liberatoria. Una leggerezza improvvisa. Una voglia sanissima di prendersi in giro, lasciar correre, buttarsi nelle cose che piacciono pensando ma sì, vada come vada. Ci provo.
(Ps: ho riso anche dopo. A libro chiuso, mentre spazzolavo i denti, infilavo la maglietta, legavo le stringhe delle scarpe).
Ma a un certo punto della storia le cose si sono fatte un po’ più serie, o almeno questo è quello che ho sentito nel mio stomaco, eppure non è venuto meno lo spirito divertente e brioso (e paranoico, questo sempre) del racconto. Che poi non poteva che andare così. Le paure fanno il loro dovere, non possono farti sorridere-ridere e via, tutti a sbellicarsi. Arriva sempre il momento in cui riprendono in mano la situazione e tu, obbediente, abbassi la testa e magari ti arrendi.
«Forse ho esagerato. Forse ho sopravvalutato le mie possibilità. Forse ho sperato che realizzare un sogno mi guarisse. Forse ho sognato troppo in grande.»
Su questo non ho ancora le idee chiare. Dipende dai giorni. Sognare in grande mi fa stare bene, ne sono sicura. Certo, poi prendo delle bastonate terribili se i miei sogni si perdono nel vento o affogano nell’acqua o boh. Spariscono e basta.
Ma provo sempre un gran sollievo quando scopro che le cose belle riescono a cavarsela e sopravvivere anche nelle circostanze più assurde e impensabili. Come questa storia. Che è la storia di Patrizia, ma può essere la storia di tanti altri. Patrizia in viaggio da Torino a Dublino per salvare un amico che vuole farla finita. Patrizia che ha tante paure ma che, forse, ha anche la giusta incoscienza per tentare di affrontarle. Patrizia può assomigliarci, ricordarci un’amica o una persona incontrata tanti anni fa. Quella che non capivi perché ti pareva “strana”, quella che aveva chissà cosa in testa, ma che ti ha lasciato comunque qualcosa di buono a cui aggrapparti.
A me le cose belle piace trovarle anche qui, nelle storie delle persone che incrocio per caso, un pomeriggio d’estate, dentro le pagine di un libro.
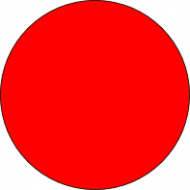
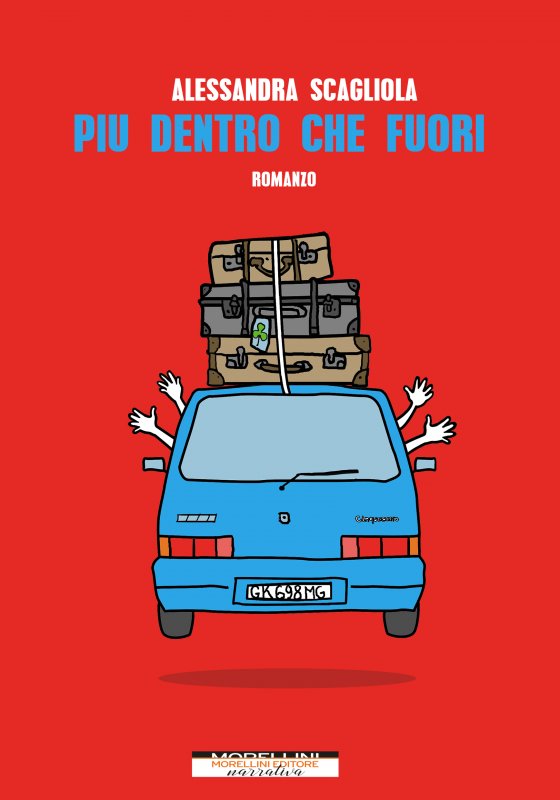
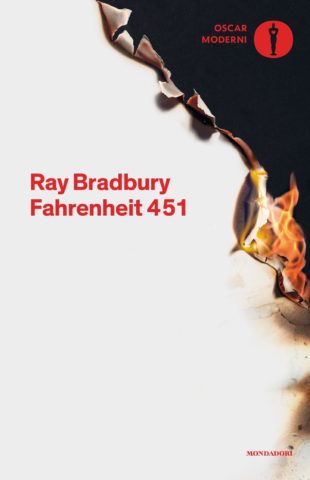


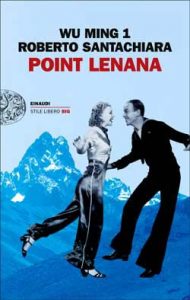
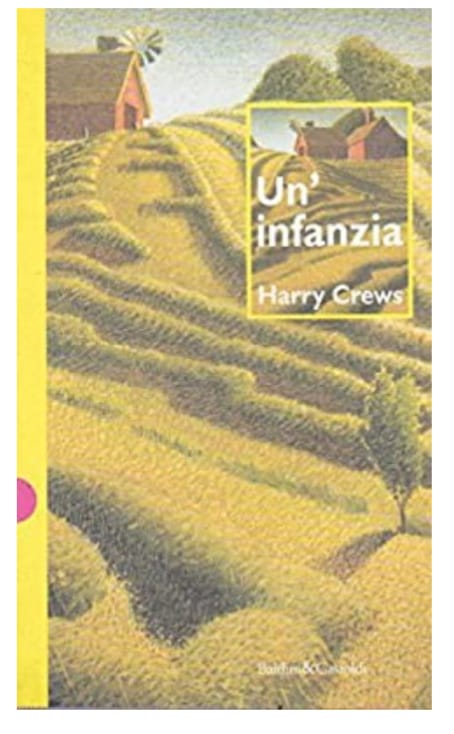
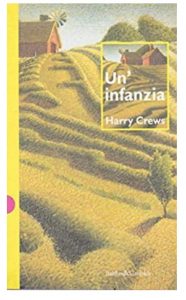

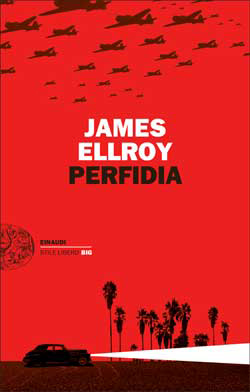
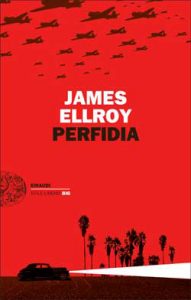



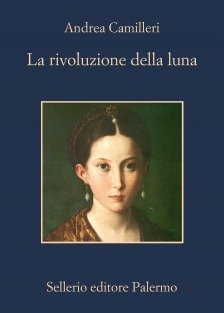
 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi
 di Giovanni Di Prizito
di Giovanni Di Prizito