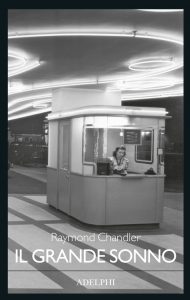 di Luca Palladino
di Luca Palladino
«Baciami, Chioma d’argento».
Un repentino e terribile silenzio piomba sulla conversazione. Eppure solo un attimo prima lei e lui parlavano del più e del meno con una certa nonchalance, discutevano amabilmente del tempo, dell’età, del lavoro, del significato della parola «coprifuoco», roba così. Poi di colpo sono finiti gli argomenti come una pistola che s’inceppa all’improvviso, così è arrivata la pesante cappa di silenzio a prendersi la scena. Ora sia lui che lei cercano in giro per la mente qualcosa di sensato da dire. Ma niente, non succede niente. I due, presi da un certo disagio, girano il capo di qua e di là alla ricerca di un altrove impossibile. Adesso lei afferra una ciocca di capelli guardandoseli con molta attenzione come se cercasse chissà che. Lui, invece, afferra il bicchiere pur sapendo che è vuoto.
Nel frattempo un uomo corpulento sulla trentina entra nel locale, e prima di accomodarsi al bancone e ordinare uno scotch doppio, dà un’occhiata alla coppia con la coda dell’occhio. Ha l’aria di essere un investigatore privato: che non sia il famoso detective Philip Marlowe? Sì, dev’essere proprio lui, anzi è proprio lui. Si è acceso una sigaretta anche se nel 2020 non si può, il barman glielo fa presente ma per lui a quanto pare è ancora il 1939.
L’orologio appeso al muro segna le sette della sera. Lo so perché sono seduto proprio di fianco alla coppia in stato di disagio, vedo le grandi spalle del detective Marlowe, l’orologio è proprio sulla sua testa, cioè di fronte a me. Vedo le smorfie del suo volto spigoloso attraverso lo specchio dietro al bancone. Ho in mano un libro, Il grande sonno, di Raymond Chandler edito da Adelphi edizioni. È ben strano che nel nostro paese esista una casa editrice così… come dire?… di un’avanguardia paradossale. Addirittura pare che adesso si sia messa in testa di pubblicare tutte le opere di Chandler: penso che non me ne perderò nemmeno una.
Una nuvola di fumo si espande sul capo di Philip Marlowe mentre la ragazza accanto, strabuzzando gli occhi, prende la decisione di svignarsela salutando goffamente il suo accompagnatore che rimane da solo a fissare il bicchiere vuoto. Marlowe la guarda uscire abbozzando un sorriso, ha ordinato un altro scotch doppio, e si è acceso un’altra sigaretta. È alle prese con una nuova indagine, un ricco signore lo ha incaricato di scovare una persona scomparsa, un irlandese di Clonmel, un certo Rusty Regan. Lo so perché c’è scritto nel libro che ho tra le mani.
Il ragazzo rimasto solo al tavolo di fianco al mio respira profondamente. Marlowe, invece, si è scolato il suo scotch doppio tutto d’un fiato. Ora ha lo sguardo fisso nel vuoto, forse sta pensando al caso da risolvere, oppure riflette sul grande sonno, quello che si dorme quando si è morti, o forse sta pensando alle labbra gelide di chioma d’argento che non bacerà mai più…
D’un tratto i miei occhi e quelli di Marlowe s’incontrano attraverso lo specchio, distolgo lo sguardo in un batter d’occhi.

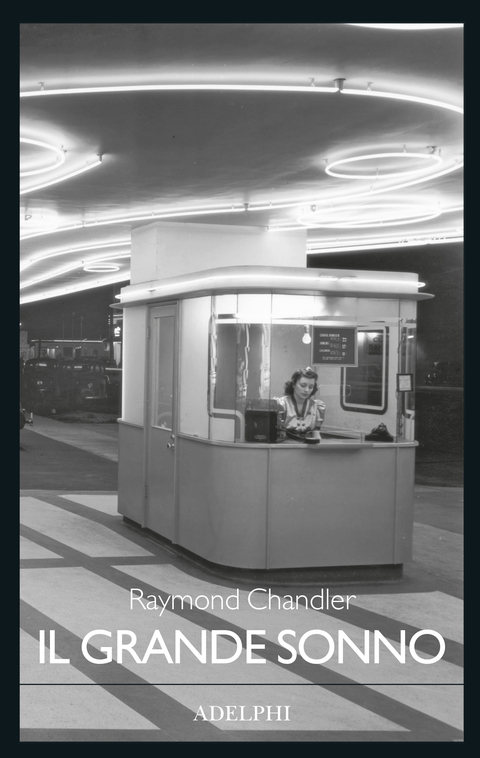
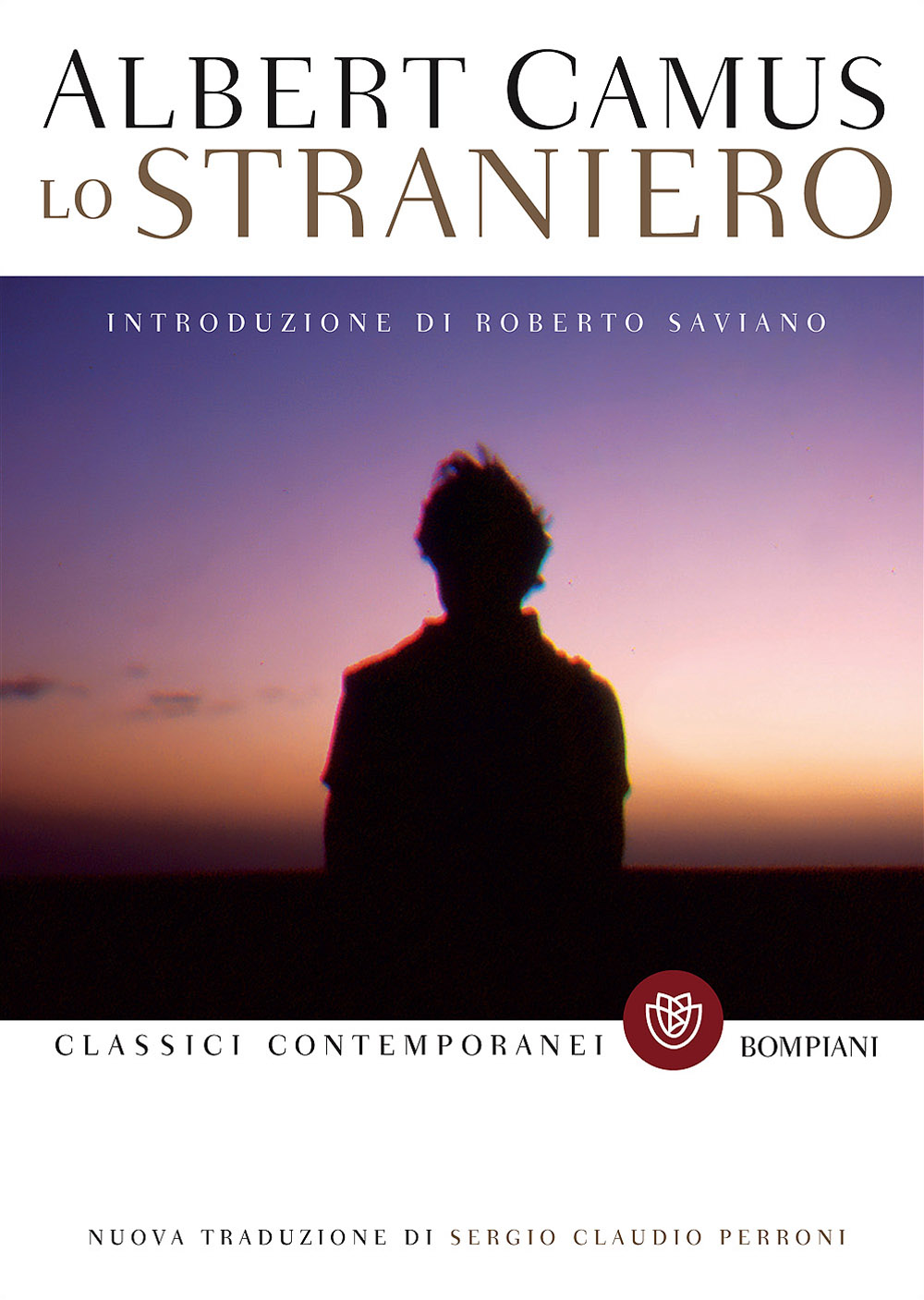
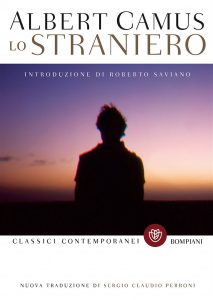 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi
 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi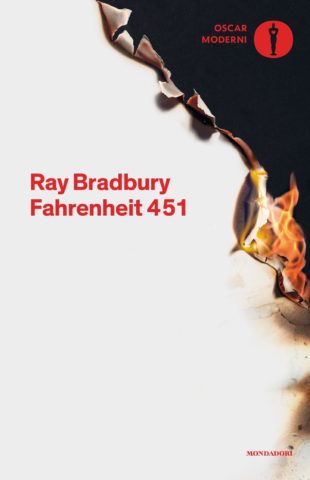

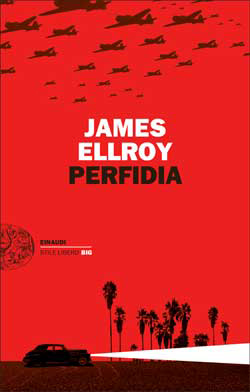
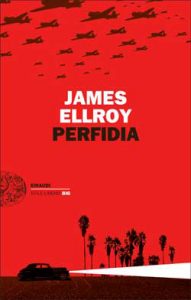
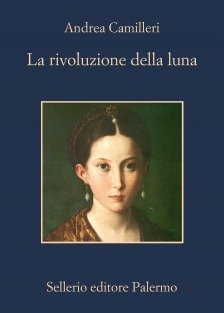
 di Robespierre Capponi
di Robespierre Capponi

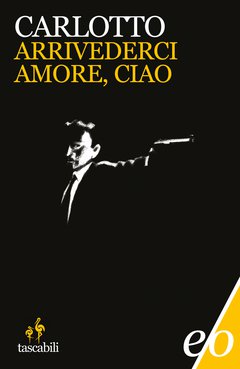
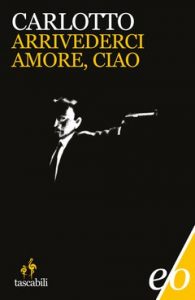

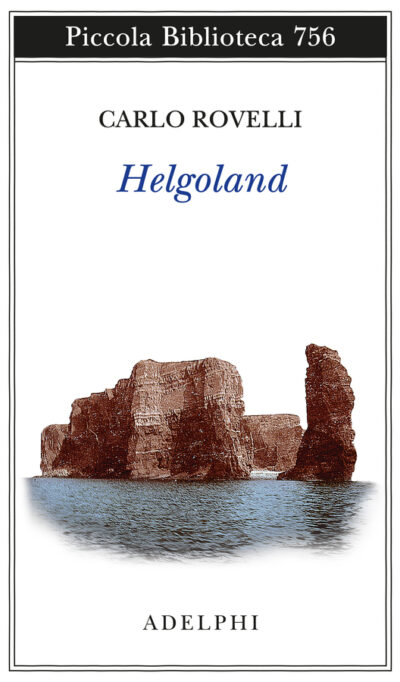

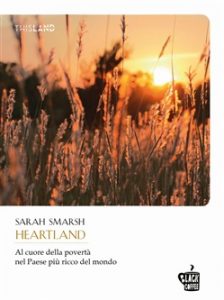 di Alessandra Banfi
di Alessandra Banfi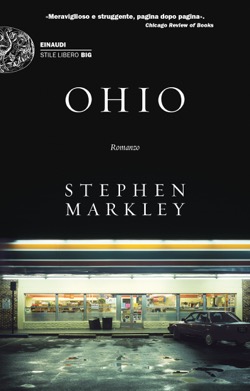
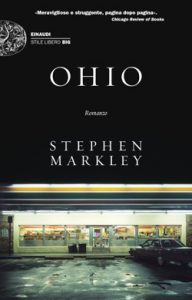 ‹‹Per ora sappiate che è successo qualcosa.››
‹‹Per ora sappiate che è successo qualcosa.››




 di Sara Maria Morganti
di Sara Maria Morganti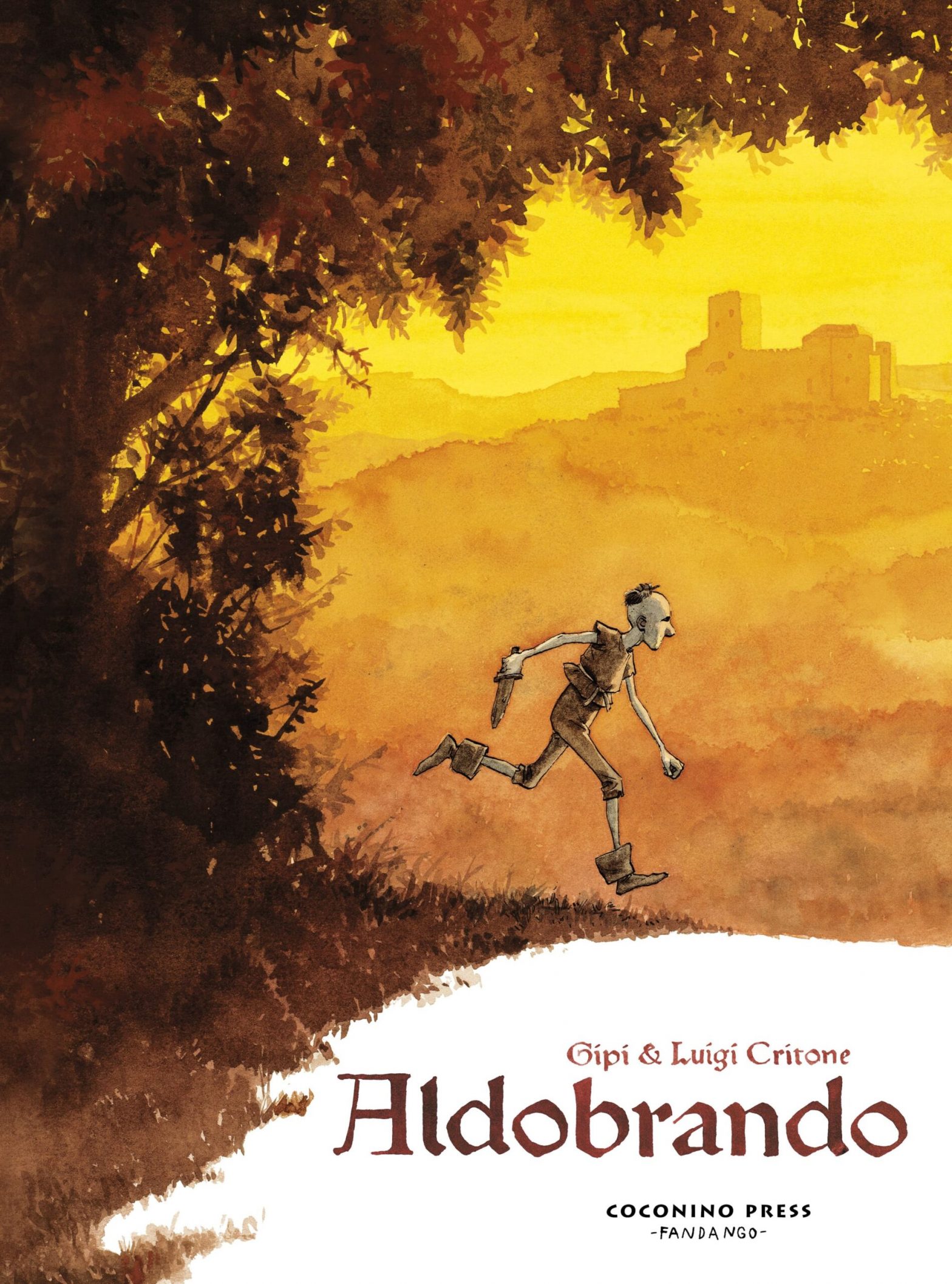
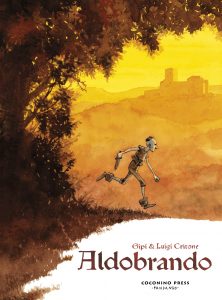
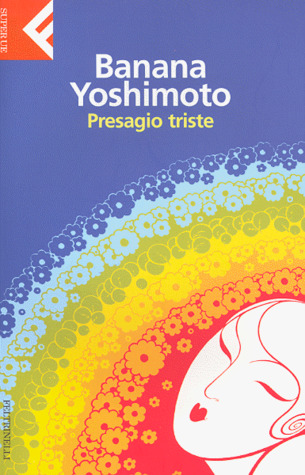
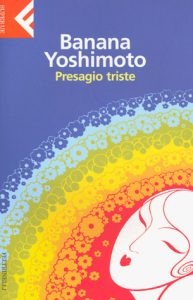 di Alessandra Banfi
di Alessandra Banfi


 di Alessandra Banfi
di Alessandra Banfi